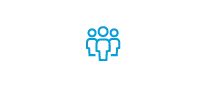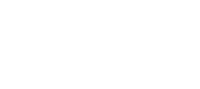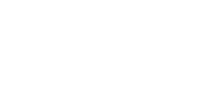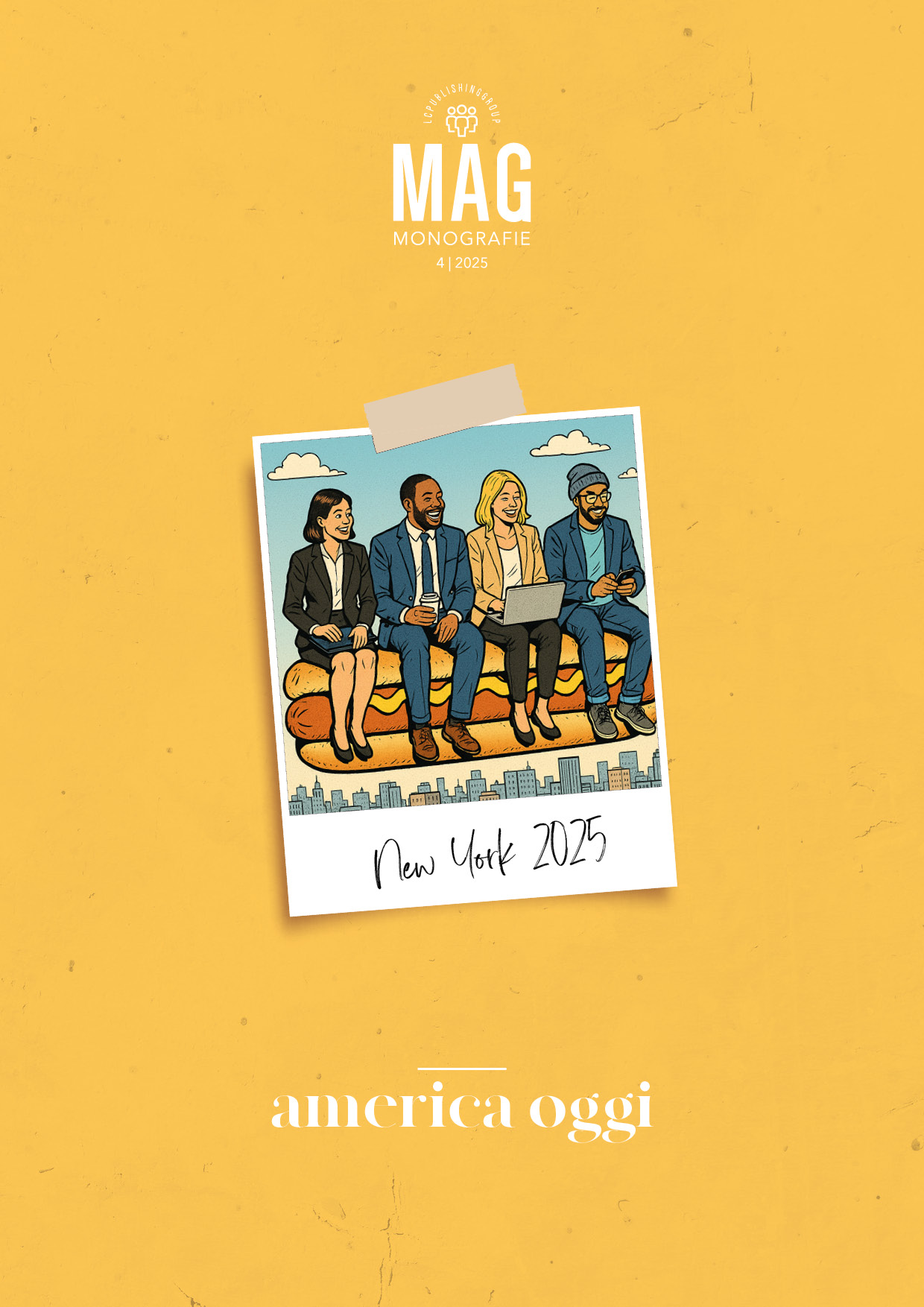Sugar tax, un percorso ancora incerto tra proroghe e ripensamenti
a cura di Giovanni Iaselli – partner di DLA Piper
A distanza di quasi sei anni dalla sua introduzione, la Sugar Tax continua a rappresentare una delle misure più controverse della politica fiscale italiana. Prevista dalla Legge di Bilancio 2020 (art. 1, commi 661-676, L. 160/2019) e più volte rinviata – da ultimo con il D.L. 95/2025 – l’imposta sulle bevande edulcorate è attualmente destinata ad entrare in vigore il 1° gennaio 2026. Tuttavia, ulteriori proroghe appaiono tutt’altro che escluse: il Documento programmatico di bilancio prevede, infatti, il differimento al 2027 per l’entrata in vigore della “nuova” imposta.
Configurandosi quale behavioural tax, la misura nasceva con l’intento di disincentivare il consumo di bevande zuccherate attraverso un incremento del relativo carico fiscale. L’imposta si applica all’immissione in consumo di bevande analcoliche edulcorate – sia prodotti finiti che da diluire – rientranti nelle voci NC 2009 e 2202 della nomenclatura combinata. Si tratta, in particolare, di prodotti (condizionati per la vendita) aventi un titolo alcolometrico inferiore o uguale a 1,2% in volume, ottenuti con l’aggiunta di edulcoranti – di origine naturale o sintetica – idonei a conferire sapore dolce e destinati al consumo alimentare umano.
L’imposta è fissata in 10 euro per ettolitro per le bevande finite e in 0,25 euro per chilogrammo per i prodotti da diluire, e diviene esigibile in momenti differenti a seconda della provenienza:
- dall’Italia, generalmente all’atto della cessione ai consumatori finali o ai rivenditori;
- da altri Paesi dell’UE, all’atto della ricezione da parte dell’acquirente nazionale;
- da Paesi extra-UE, al momento dell’importazione definitiva in Italia, secondo le modalità previste per i diritti di confine.
Nonostante il lungo percorso legislativo, la misura resta oggetto di un acceso dibattito. La distanza temporale tra la sua ideazione e la data prevista per la sua ipotetica effettiva applicazione ne ha progressivamente svuotato la portata originaria, rendendola oggi più simbolica che realmente funzionale. Se nel 2020 l’introduzione poteva apparire coerente con un contesto di crescente attenzione alla salute pubblica e, al contempo, con l’esigenza di reperire nuove entrate fiscali, a distanza di cinque anni il quadro economico e sociale mutato richiederebbe – anche ove si dovesse decidere di non abrogarla – comunque un ripensamento. Inoltre, la grande incertezza generata dai continui rinvii della normativa rende difficile pianificare strategie industriali e finanziarie, attenuando gli incentivi alla riformulazione dei prodotti e agli investimenti di lungo periodo.
Già nel 2021 uno studio Nomisma, commissionato da Assobibe, stimava che l’applicazione della sugar tax avrebbe determinato una contrazione delle vendite di bevande analcoliche del 15,6% nei primi due anni. Tali proiezioni, se confermate, non potrebbero che aggravare la situazione di un comparto già in difficoltà, come dimostrano i dati Circana relativi al 2025 diffusi da Assobibe: nei mesi estivi del 2025 – tradizionalmente il periodo di picco stagionale – le vendite del settore hanno registrato una significativa riduzione rispetto all’anno precedente, con cali diffusi in quasi tutti i segmenti (dalle aranciate ai tè freddi, dalle toniche alle gazzose).
In sostanza, le imprese del comparto si trovano oggi ad affrontare una fase di contrazione dei consumi, aggravata da un clima di perdurante incertezza normativa dovuto ai continui rinvii di una disciplina che, se applicata, avrebbe un impatto rilevante sull’intera filiera – sia per i costi connessi al tributo in sé traslati sui consumatori, sia per quelli derivanti dalla necessità di predisporre una struttura organizzativa idonea a gestire gli adempimenti di compliance. Contrazione dei consumi che, come accaduto in altri paesi, rischia di penalizzare soprattutto i consumatori meno abbienti.
L’eventuale entrata in vigore della sugar tax consentirebbe certamente all’Italia di allinearsi a modelli europei che già prevedono prelievi selettivi su beni ad elevato contenuto di zuccheri aggiunti. Tuttavia, la questione di fondo resta immutata: se la finalità sanitaria è condivisibile, la sua attuazione non può prescindere da un equilibrio con le esigenze di sostenibilità economica e produttiva del settore. Non a caso, anche altri Stati membri – come la Lituania – hanno recentemente annunciato l’intenzione di rinviare ulteriormente l’entrata in vigore di misure analoghe.
In definitiva, la sugar tax appare oggi come una misura sospesa tra finalità condivisibili e difficoltà applicative, in un contesto economico che ne ha progressivamente ridotto la ragion d’essere. Il rinvio al 2026, e la probabile ulteriore proroga al 2027, offrono – forse – un’ultima occasione per ridefinirne l’impianto e valutarne la reale sostenibilità; diversamente, rischierebbe di tradursi in un provvedimento meramente simbolico, incapace di incidere sui comportamenti di consumo e, al tempo stesso, gravoso per un comparto già in evidente sofferenza.