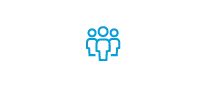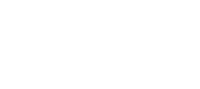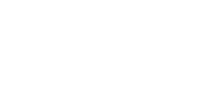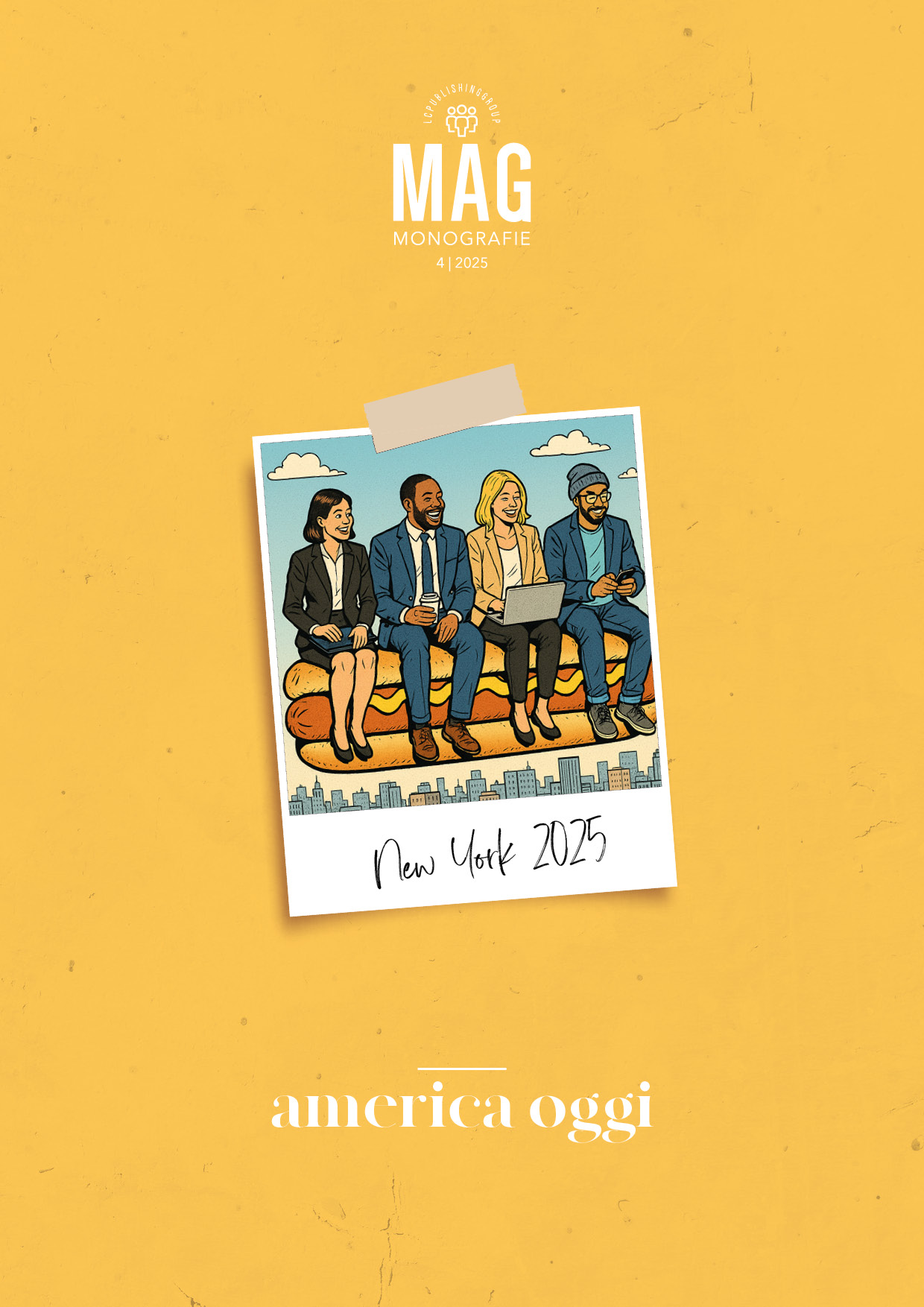Coronavirus e attestazione “virus free” per gli alimenti
Le vendite dei prodotti alimentari hanno registrato un significativo incremento in Italia durante il periodo di diffusione della pandemia coronavirus.
Nella prima settimana di marzo 2020, il volume delle vendite nella gdo è aumentato dell’11% rispetto al medesimo periodo del 2019 (+21% al Sud, +13% al Centro e + 8% al Nord) e gli acquisti di prodotti alimentari online segnano un +82% (fonte Nielsen).
Completamente diversa invece è la situazione nell’export alimentare dove l’intero settore sta risentendo delle difficoltà collegate alla diffusione del coronavirus. A questo si aggiunge il calo di fiducia verso i prodotti italiani da parte dei consumatori esteri.
Secondo un’analisi di Coldiretti sarebbero a rischio circa 44,6 miliardi di euro di esportazioni agroalimentari determinati dai vincoli alle frontiere, dalle difficoltà logistiche e, in generale, dal calo della domanda estera.
Basti pensare al rischio che le limitazioni (o la chiusura) al traffico su gomma della frontiera del Brennero può comportare, considerato che circa due terzi delle esportazioni agroalimentari verso gli altri paesi europei passano attraverso quel valico. A ciò si aggiunga che, come denunciato dal Presidente di Confitarma, più della metà dei Paesi del mondo sta bloccando i movimenti italiani nei propri porti.
Superate queste evidenti barriere logistiche, intervengono delle richieste, del tutto ingiustificate, da parte dei player della filiera alimentare che, per combattere un timore scientificamente inesistente, chiedono che i prodotti agroalimentari italiani siano corredati da un’attestazione “virus free”.
E infatti, il direttore scientifico dell’EFSA (European Food Safety Authory – con sede a Parma) ha dichiarato che: “Le esperienze fatte con precedenti focolai epidemici riconducibili ai coronavirus, come SARS-CoV e MERS-CoV, evidenziano che non si è verificata trasmissione tramite il consumo di cibi. Al momento non ci sono prove che il coronavirus sia diverso in nessun modo”.
Pertanto, richiedere allo stato un’attestazione “virus free” rappresenta una richiesta irricevibile nei rapporti tra le imprese che operano nel settore agroalimentare. Non solo, l’eventuale imposizionedi questa configurerebbe anche un’ipotesi di pratica sleale.
La normativa europea (ed in particolare la Direttiva 2005/29/CE) individua come sleali quelle pratiche commerciali che:
(i) sono contrarie ai requisiti della diligenza professionale, per tale intendendosi “la misura della speciale competenza e attenzione che ragionevolmente ci si deve aspettare da parte di un professionista conformemente ai requisiti dell’onesta pratica di mercato e/o del principio generale della buona fede nel settore di attività del professionista”.
(ii) hanno la probabilità di falsare in misura rilevante il comportamento economico del consumatore medio ossia pratiche rivolte ad alterare sensibilmente la capacità del consumatore di prendere una decisione consapevole, inducendolo pertanto ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.
Sono poi definite due categorie specifiche di pratiche commerciali come particolarmente sleali: le pratiche commerciali ingannevoli (per azioni od omissioni) e le pratiche commerciali aggressive.
Le prime sono azioni svolte dai professionisti nella promozione e vendita dei loro prodotti che contengano informazioni false e siano, pertanto, non veritiere ma anche laddove, pur presentando un’informazione corretta, la presentazione complessiva dei prodotti si concretizzi in un inganno (anche potenziale) verso il consumatore medio. Le altre, sono rappresentate da quelle condotte del professionista che inducano o siano idonee a indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.
Tali norme di matrice europea, recepite in Italia nel Codice del Consumo, trovano poi similare recepimento negli altri Stati Membri e quindi applicabili anche agli scambi transfrontalieri in ambito UE. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato, anche di concerto con le omologhe autorità europee, ha il potere di inibire la continuazione delle pratiche commerciali scorrette e ne elimina gli effetti. Le sanzioni avverse le pratiche commerciali scorrette possono arrivare (con varie gradazioni di intensità) fino a 500mila euro.
Le disposizioni in tema di pratiche commerciali sleali sono oggetto di aggiornamento, in parte per effetto della Direttiva Consumatori 2019, che dovrà essere recepita entro il 1 luglio 2021, ma soprattutto della Direttiva (UE) 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare le cui disposizioni saranno recepite entro il 1 maggio 2021 e troveranno applicazione dal 1 novembre 2021.
Auspicabile anche un intervento normativo ad hoc per fronteggiare gli attacchi strumentali, la concorrenza sleale, le restrizioni e le discriminazioni verso i prodotti italiani.
Nel frattempo, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha attivato una casella di posta elettronica (coronavirus.merci@esteri.it), dove segnalare le difficoltà riscontrate nelle esportazioni dei prodotti italiani.
Avv. Paola Ghezzi – Partner Studio CMS
Avv. Massimo Alpigiani – Senior Associate Studio CMS
Leggi l’articolo: Manovra economica, Plastic Tax e Sugar Tax