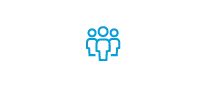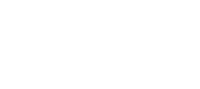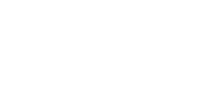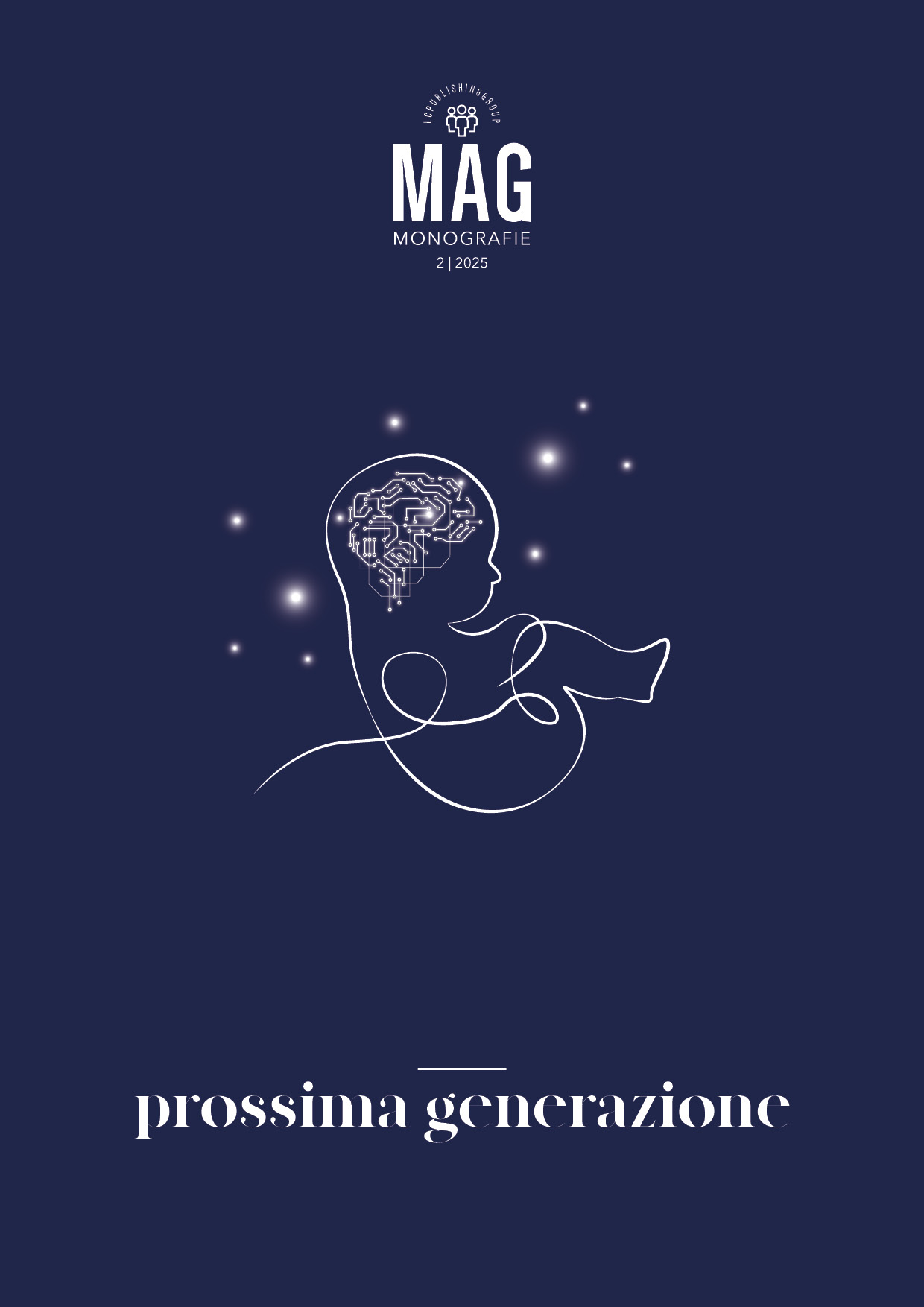Quando si tratta di cibo, l’Italia si fa Popolo
di letizia ceriani
Agli italiani puoi dire tutto…ma non toccargli la pastasciutta. Qualche settimana fa, il quotidiano britannico Financial Times pubblica un’intervista della giornalista Marianna Giusti ad Alberto Grandi, storico dell’alimentazione e professore associato all’Università degli Studi di Parma, nel cuore della food valley, diventato famoso per un testo dall’esplicitamente provocatorio titolo “Denominazione di Origine Inventata”, da cui nel 2021 nasce anche un podcast.
Nell’articolo, vengono apparentemente sfatati alcuni piatti simbolo della tradizione culinaria nostrana, quali carbonara, panettone, tiramisù e parmigiano. Ed è il Consorzio di quest’ultimo ad aver scagliato – insieme a tutte le principali testate italiane – la prima pietra, rivendicando l’appartenenza, l’origine e l’unicità del formaggio in questione. Ma cosa dice di così blasfemo il prof. Grandi?
Nell’intervista si legge che «prima degli anni ’60 le forme di parmigiano pesavano solo circa 10 kg (rispetto alle pesanti forme da 40 kg che conosciamo oggi) ed erano racchiuse in una spessa crosta nera. Aveva una consistenza più grassa e morbida rispetto a quella attuale» e poi, rullo di tamburi, che «la sua esatta corrispondenza moderna» sarebbe «il parmigiano del Wisconsin». Quello che infastidisce di più delle parole di Grandi è che in qualche modo metta in discussione quello che di fatto è un rito. La cucina italiana è senza dubbio un’istituzione, sacra, intoccabile e indiscutibile.
Il cibo in Italia – a prescindere dalla forma “alta” in versione fine dining o “bassa” dei piatti casalinghi – è cultura e questa è un’idea condivisa da tutte le parti sociali e politiche del Belpaese. Un’idea condivisa innanzitutto da Grandi.
Ma analizziamo più nel dettaglio il cuore della polemica. Leggendo con attenzione l’intervista del Financial Times, risulta evidente come l’operazione del prof. Grandi non sia quella di insultare o canzonare la cucina italiana, ma di divulgare evidenze storiche, analizzando come alcuni piatti tipici abbiano incontrato trasformazioni, modifiche ed evoluzioni, non solo su suolo italiano, ma anche nei luoghi dove gli italiani hanno cercato fortuna. Nel caso del Parmigiano, sono stati proprio gli emigrati delle zone del Po’ ad aver ripreso la produzione del formaggio in Wisconsin, sfruttando l’abbondanza di materia prima della zona – le vacche da latte – riproponendo la lavorazione appresa in Italia, coniando il nome anglofono “Parmesan”. Il risultato è un formaggio totalmente diverso, lasciato stagionare in una spessa crosta nera come conservante naturale. Proprio come le antiche consuetudini vorrebbero. In Wisconsin il Parmesan è rimasto tale e quale, non ha subito variazioni.
L’invito è a diffidare di un certo tipo di storytelling, o meglio, a considerare la tradizione come impura, ovvero costruita nel tempo, in continuo divenire nell’innesto mutevole dello storico. Quasi 70 sono i milioni di italiani in patria, ma 80 i milioni nel mondo, amanti delle proprie tradizioni, della domenica in famiglia e del panettone a Natale. La nostalgia di casa fa rivivere i propri miti – e i propri fantasmi – potenzialmente ovunque, e questo è quello che è accaduto al cibo, entrato a far parte non solo dell’immaginario collettivo mondiale ma dell’identità nazionale.
Produttori, ristoratori e Consorzi hanno additato a Grandi come dissacrante e offensivo, solamente perché ha evidenziato come le ricette non vadano concepite come pure e cristallizzate ma come figlie di contaminazioni e trasformazioni.
Il Parmigiano Reggiano non sarebbe quello che è, se le tecniche non fossero cambiate, le zone di produzione non si fossero ampliate, e il gusto non si fosse adeguato ai palati attuali. La pastasciutta stessa è diventata il piatto italiano per eccellenza in America, nonostante già nel Seicento i napoletani fossero conosciuti come “mangia-maccheroni”, mentre al Nord imperava la polenta come principale ingrediente.
La vivace opposizione alle parole di Grandi fa riferimento anche al fenomeno dell’italian sounding che consiste nel commerciare e promuovere prodotti gastronomici evocando illecitamente il marchio “made in Italy”. Come Grandi stesso sottolinea in una delle ultime puntate del suo podcast “Doi”, l’italian sounding è sì un reato in Europa, ma è anche sintomo di una qualità e un’unicità riconosciute all’universo mondo. Se i nostri prodotti non fossero così buoni, in poche parole, nessuno li imiterebbe. È anche vero, però, che i nostri prodotti certificati all’estero risultano come alta gamma e che quindi le imitazioni finiscono per essere la prima scelta di chi non se li può permettere. Il fenomeno si inserirebbe, a parere del prof. Grandi, all’interno di uno specifico equilibrio economico.
Si legge sul Financial Times: «Italian cuisine really is more American than it is Italian». La cucina italiana sarebbe quindi tanto americana quanto italiana? Con gli strumenti forniti, possiamo trarre le dovute conclusioni dell’affermazione che è solo apparentemente provocatoria.
Storia e tradizione sono due cose fondamentalmente diverse e la fissazione per una tradizione culinaria vergine e immutabile potrebbe essere letta come “l’ultimo baluardo” di un’identità nazionale che non c’è praticamente mai stata o che comunque ha perso i suoi punti di riferimento. Dato eclatante il nuovo protezionismo che sta entrando a far parte dell’agenda politica del Governo Meloni e le polemiche contro la farina di grillo e la carne sintetica.
Di fronte a tutto quello che è stato detto, a noi basti una manciata di assunti: la posizione di Grandi è chiara, competente e – per quanto opinabile su certi aspetti – ben argomentata in dieci salse diverse; sconvolgere la tradizione destabilizza sempre, soprattutto noi italiani, orgogliosi e campanilisti… ma rispettare la storia rimane uno dei principali criteri per costruire un’opinione.