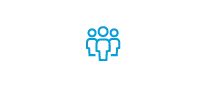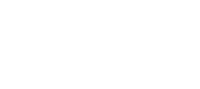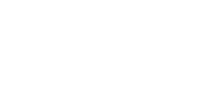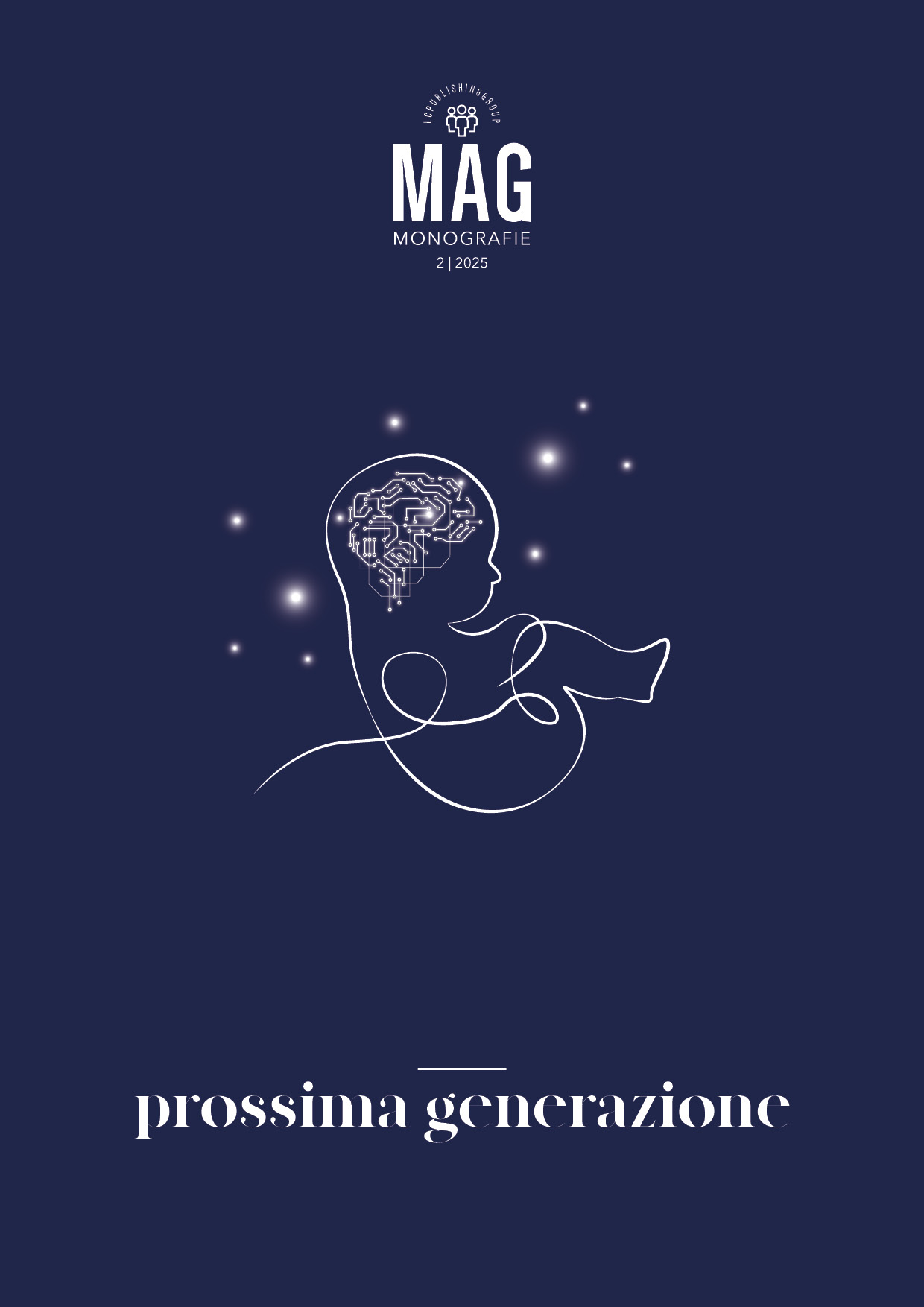Babylon e la metafora del mercato
di giuseppe salemme
Babylon non è un capolavoro; e non è un film brutto. È un buon film. Da sette. O, per chi preferisce, da tre stelline, anche quattro. È a tratti spettacolare, ben fotografato e ben girato (il regista, Damien Chazelle, è quello dell’ottimo Whiplash, del buon La La Land e del dimenticabile First Man). Ma è molto lungo (3 ore e 10) e forse si perde eccessivamente tra chiacchiere e trovate a effetto soprattutto verso la fine, quando anche chi ha chiuso gli occhi per una decina di minuti ha capito benissimo quello che l’autore vuole dire (per chi non l’avesse capito, ne parliamo nel podcast abbinato a questa recensione).
Molti ghirigori, insomma, quando in realtà la cosa migliore del film è il concetto alla base dell’intreccio.
Babylon è ambientato in un momento preciso della storia: quello del passaggio dal cinema muto all’era del sonoro. È il momento in cui, dall’oggi al domani, un’intera industria cambia: nuovi strumenti, nuovi prodotti, nuove figure professionali, nuovo modo di lavorare. E così, quello che ieri era essenziale oggi d’improvviso non conta quasi più. In un terrificante istante ci si rende conto che la star di turno, protagonista di successo di innumerevoli blockbuster, dal fisico scultoreo e dal volto iper espressivo, formidabile nel muoversi sul set a favore di telecamera, ha una pessima dizione. Quando si muove è troppo rumorosa, disturba i microfoni e l’audio distorce. Non ha voglia di cambiare modo di lavorare, e forse non ha nemmeno la pazienza per ripetere take dopo take, una star come lei. Persino il regista, sovrano assoluto del set, è costretto ad abdicare al suo trono per i pochi, infiniti secondi che separano il suo “cut!” dal pollice in su del microfonista.
Si tratta di una metafora semplice ma potente del modo in cui funziona il mercato, e di come qualsiasi posizione di vantaggio, anche costruita con merito, sia frutto di condizioni ambientali contingenti e sempre mutevoli. Nemmeno il mercato legale italiano sfugge a simili dinamiche, e chi legge MAG abitualmente lo sa bene. L’arrivo delle law firm anglosassoni ne ha già dato la prova, cambiando in pochi anni il modo di intendere e svolgere la professione di avvocato e costringendo l’aristocrazia legale italiana a correre ai ripari e adattarsi al nuovo contesto, cedendo parte della propria posizione di predominio: anche qui abbiamo visto le star del mercato costrette all’improvviso ad affannarsi per rimanere in gioco.
La domanda allora è: quale sarà la prossima svolta? Il prossimo momento che costringerà tutti a rivalutare i propri punti di forza e i propri punti deboli, a evolvere e a riposizionarsi di conseguenza?
Difficile non andare col pensiero alle nuove intelligenze artificiali creative: l’effetto “wow” che abbiamo provato tutti al primo contatto con ChatGpt non deve essere stato troppo dissimile da quello provato dai nostri antenati che, negli anni ‘20, scoprirono che le figure in movimento sullo schermo potevano anche parlavano, cantare, suonare. Le IA generative sono (per ora) imperfette, imprecise e anche parecchio inquietanti; ma se è vero che hanno fatto sì che qualcuno pronunciasse la parola “obsoleto” addirittura in riferimento a Google (e questo qualcuno è chi Google magari la comanda), quanto ha senso che gli avvocati si ripetano che non c’è nulla di cui preoccuparsi? Che la macchina non sostituirà mai l’uomo? Che l’elemento creativo e la responsabilità del professionista non ammetteranno mai surrogati?
Anche gli scettici sul cinema sonoro non erano pochi. Forse erano addirittura la maggior parte: era uso comune chiamarli “talkies” per distinguerli dai “movies”. Oggi di talkies non parla più nessuno. Parliamo di cinema, e il cinema parla. Babylon lo mette in scena in maniera chiara: chi rifiuta il microfono rischia di rimanere muto.